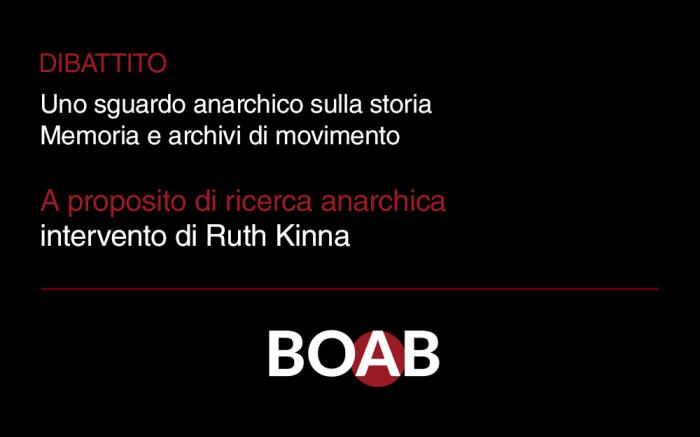A proposito di ricerca anarchica
di Ruth Kinna
In un breve saggio scritto nel 2012 mi interrogavo sulla questione della ricerca anarchica, concentrandomi in particolare sugli obiettivi della ricerca. In quel saggio articolavo l’interrogativo principale – “In che cosa consiste la ricerca anarchica?” – in tre domande secondarie: “Esistono modalità di analisi propriamente anarchiche, oppure più aperte a forme di pensiero anarchico rispetto ad altre?”; “In che modo lo studio dell’anarchismo ha concorso a plasmare la concezione delle idee e dei movimenti che ne fanno parte, e quale contributo critico e costruttivo può ancora offrire?”; “Cosa possono guadagnare le discipline e i saperi già consolidati da un approccio anarchico?”. Non penso che queste domande esauriscano l’intero spettro della questione: non ne ero convinta allora e non lo sono neppure adesso. Quegli interrogativi nascevano piuttosto da un’urgenza legata alla costruzione e alla ricostruzione del passato dell’anarchismo, un tema che, in forme diverse, hanno affrontato tutti gli autori del volume[1].
In quel periodo, mi sembrava che l’anarchismo avesse acquisito un nuovo presente, e che questo avesse inciso profondamente sul nostro modo di valutare il passato. L’influenza del post-strutturalismo e un rinnovato interesse per gli approcci teorici incentrati sui movimenti avevano contribuito a favorire un distacco dalla storia. Qual era la posta in gioco? L’argomentazione, sviluppata insieme ad Alex Prichard, si soffermava proprio sul rapporto tra passato, presente e futuro. Sostenevamo che spesso gli anarchici avevano avuto una certa ritrosia a confrontarsi con il proprio passato, anche perché avevano in larga misura accolto critiche di fatto incapaci di restituire la complessità, le istanze e gli ideali dei sostenitori del movimento nel XIX secolo. In varie ricostruzioni ormai classiche della storia d’Europa pubblicate dopo la seconda guerra mondiale (in particolare dopo il 1968), la chiave interpretativa è quella del gesto eversivo, dell’utopismo, del fallimento delle rivoluzioni e di una filosofia frammentaria. A rischio di banalizzare il dibattito dei primi decenni del XXI secolo, si può dire che da una parte l’invito era a mettere da parte le idee ormai superate di “uomini bianchi deceduti”, mentre dall’altra queste stesse idee venivano presentate come espressione di un semplice tentativo di ammantare il marxismo di una veste ribelle. In un senso o nell’altro, la conclusione era che non rimanesse molto da scoprire o recuperare. Di fatto, si poteva dunque respingere il “passato anarchico” nella sua interezza, insieme alla sua storia legata alla questione delle classi, oppure essenzialista, razionalista, terrorista, eurocentrica, elitaria, razzista, patriarcale o rivoluzionaria.
Riprendere queste riflessioni è stimolante, ma nell’insieme la mia prospettiva non è mutata: la prassi anarchica non può che essere penalizzata dal rifiuto del passato, indipendentemente dalla sua motivazione. La revisione critica e la valorizzazione delle correnti intellettuali, culturali, politiche e sociali del passato arricchiscono la nostra comprensione del presente e ci offrono strumenti per pensare futuri possibili o desiderabili. Quando si rinuncia ad approfondire le radici dell’anarchismo, ci si ritrova confinati in un eterno presente, senza punti di riferimento per immaginare delle alternative. L’anarchismo si riduce così a pochi principi isolati, oppure si trasforma in una critica delle manifestazioni di quelle forze che nella storia gli anarchici hanno saputo analizzare e attraverso cui hanno saputo mobilitare alla resistenza i gruppi emarginati.
Il dibattito ha in buona parte perso la sua forza polemica, ma la questione rimane aperta: la storia dell’anarchismo è preziosa in sé e per sé, ma riguarda sempre anche il modo in cui si costruisce l’anarchismo stesso. Le decisioni su chi o cosa studiare, sui criteri di inclusione, sull’estensione della ricerca, su dove cercare e cosa portare alla luce, sono informate da una certa concezione della tradizione e rappresentano parte integrante della sua articolazione. La storiografia non può svilupparsi al di fuori dei confini della storia anarchica, ma soltanto attraverso la narrazione di questa storia. Confini che, a buon diritto, sono oggetto di costante discussione. È proprio da questa consapevolezza che nasce lo sguardo anarchico sulla storia.
traduzione di Andrea Carbone
[1] Ruth Kinna (a cura di), The Continuum Companion to Anarchism, Continuum, New York, 2012.